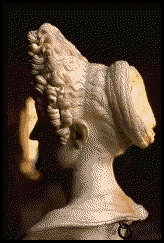Il risveglio dell'antica romana era di solito alle prime luci dell'alba, quando la vita nell'Urbe riprendeva nel pieno dei suoi ritmi causando un rumore assordante. In camera da letto si sostava ben poco, essendo questa un ambiente piccolo e poco accogliente: lo scarso arredamento del Cubiculum comprendeva di solito il letto (cubile) una cassa per gli indumenti e le cose personali (arca) il vaso da notte (lasanum) ed uno scendiletto (toral) che completava l'arredamento.
L'uso era di andare a letto con gli indumenti, quindi era ben poco quello che si doveva provvedere a mettere addosso una donna prima di uscire, giusto la palla e la tunica, che venivano sistemate accuratamente; solo che prima di presentarsi al mondo si doveva sottostare alla lunga e complessa trafila della toilette mattutina.
Si cominciava con la cura dei denti utilizzando un dentifricio a base di soda e bicarbonato di sodio; per soprassedere su chi, pur di avere un sorriso smagliante ricorreva all'uso di polvere di pomice, mastice di Chio o addirittura di urina.
Dopodiché si cominciava la cura della pelle con delle maschere di bellezza che, come da credenza di quei tempi, erano più efficaci se a base di sostanze organiche. E quindi ecco ricette a base di : corna di cervi; escrementi di pennuti; placenta, genitali e fiele; sterco ed urina di vitelli, mucche e tori, di asini e pecore; topi. Tutti questi ingredienti per acquistare le loro prerogative di cura andavano mescolati da mani sapienti con olio, grasso d'oca, succo di basilico, semi di origano, biancospino, zolfo, miele ed aceto. Una ricetta alquanto curiosa ci è giunta da Galeno, che decantava le grandi doti di una maschera a base di sterco di coccodrillo. Meglio allora quella a base vegetale, sempre da lui consigliata, a base di miele, incenso, acanto, legno di cipresso e leccio, melone ed un'alga rossa.
Ma altre se ne conoscevano, ricavate da lenticchie, miele, orzo, lupini, finocchio con aggiunta di essenze di rosa e mirra.
Importantissima poi sembra fosse la modalità di applicazione per ottenere il vero effetto richiesto: pare, ad esempio, che la maschera di urina di asina facesse effetto solo se applicata nel momento in cui sorgeva la costellazione del cane.
Mentre la maschera faceva il suo effetto, si procedeva alla depilazione, perché una donna affascinante doveva avere un corpo in cui non fossero presenti "ispidi peli pungenti", come lo stesso Plinio il Vecchio ammonisce.
A questo fine nulla di superfluo doveva essere lasciato né sulle gambe né sotto le ascelle o in altre parti del corpo, quindi si ricorreva all'uso di cerette depilatorie e creme: il "psilothrum" e il "dropax" erano composti a base di pece greca, resina, cere e sostanze caustiche, disciolte nell'olio. Inoltre si ricorreva alle pinzette, chiamate "valsellae", di solito in metallo, ma ritrovate anche in oro ed argento, di varie misure e fogge, con cui si inseguivano e debellavano anche i peli più indomiti.
Finita anche questa parte della preparazione si poteva passare al trucco vero e proprio.
A questo scopo  le matrone romane potevano contare su un ricchissimo arsenale di belletti, profumi, balsami e unguenti, alla cui preparazione una schiera di "unguentarii" era adibita, presso i loro ricchi e ricercati negozi posti nell'Urbe, concentrati nel Vicus Thotiarius e nel Vicus Unguentarii, al Velabro.
le matrone romane potevano contare su un ricchissimo arsenale di belletti, profumi, balsami e unguenti, alla cui preparazione una schiera di "unguentarii" era adibita, presso i loro ricchi e ricercati negozi posti nell'Urbe, concentrati nel Vicus Thotiarius e nel Vicus Unguentarii, al Velabro.
I vari tipi di belletti erano conservati in particolari scatolette equiparabili ai nostri odierni beauty-case, ma molto più decorati e ricercati, tenuti come fossero piccole casseforti, perché racchiudevano i segreti di bellezza delle loro proprietarie.
Al suo interno, boccette in vetro soffiato, in pasta vitrea, in terracotta ed alabastro, conchiglie ed ambra, erano i contenitori per le magiche sostanze che abbellivano le donne.
Si cominciava con una base di fondotinta, principalmente composta da biacca o carbonato di piombo mescolato a miele o ad altr e sostanze grasse, e posto sulla pelle così o colorato con salnitro, feccia di vino o ocra rossa, quindi spalmato uniformemente in uno strato piuttosto spesso.
e sostanze grasse, e posto sulla pelle così o colorato con salnitro, feccia di vino o ocra rossa, quindi spalmato uniformemente in uno strato piuttosto spesso.
Queste sostanze erano assolutamente tossiche, e la cosa era ben nota alle romane che però non avevano nessuna intenzione di rinunciare alle loro ricercate e costose sostanze per rendersi belle, suscitando in questa loro ossessione le critiche sarcastiche di poeti e commediografi latini, che non lesinano velenose e sarcastiche critiche a tali costosissime pratiche femminili.
"Riccioli, trucco, belletto, cerone e denti hai comprato. Con la stessa spesa compravi una faccia nuova", commenta Lucilio sin dal II secolo a.C., ben poco cavallerescamente, nel XVI libro delle sue Satire.
Marziale non è meno caustico: "Ovunque tu passi, fai pensare che Cosmo (ndr, Cosmo era il più noto profumiere contemporaneo a Marziale) stia traslocando e che essenze profumate escano a profusione da un flacone agitato. Non mi va, Gellia, che tu prenda gusto a queste sciocchezze straniere. Lo sai che il mio cane potrebbe essere così profumato!" (Epigrammata, 3,559).
Ovidio non pare più conciliante anche se è prodigo di consigli.
"Ma che l'amante non vi colga mai con i vasetti delle vostre creme. L'arte che vi fa belle sia segreta. Chi non vi schiferebbe nel vedervi la feccia cosparsa per tutto il viso, quando vi scorre e sgocciola pesante tra i due tiepidi seni? E che fetore l'esipo (ndr, tipo di lanolina) emana, rozza spremitura del vello immondo di un caprone, fetido anche se viene da Atene! E non vi approvo quando v'applicate in pubblico misture di midollo di cerva o vi fregate davanti a tutti i denti. Queste cure fanno belle, ma son brutte a vedersi. Spesso ciò che ci piace, piace quando è fatto, mentre si fa dispiace." (Ars amatoria, 209-218).
Come detto tutte queste frecciate velenose in nulla scoraggiavano le matrone, che continuavano la loro preparazione marcando le sopracciglia con antimonio polverizzato, detto "stibium" o con nerofumo, "fuligio", truccando le palpebre con ombretti verdi, prodotti con la malachite, ed azzurri, frutto dell'azzurrite polverizzata. Per le labbra invece i rossetti erano ricavati dal gelso, dal fuco, da estratti animali e vegetali, o da sostanze minerali,come il cinabro, il minio ed il gesso rosso.
Per dare un tocco di salute, come si diceva una volta, sulle guance si stendeva una terra rossa che conferiva pomelli coloriti in contrasto piuttosto netto con il bianco del resto della pelle.
Il trucco, la preparazione, la stesura di queste sostanze, era affidata alle esperte mani delle "Cosmetae", schiave appositamente istruite che di volta in volta sceglievano i trucchi più adatti all'abito della padrona, scioglievano i vari ingredienti con la saliva e mescolavano il tutto in piccoli recipienti aiutandosi con speciali spatoline, cucchiai e miscelatori in legno, osso, avorio, vetro e metallo.
Il tocco di classe finale erano un piccolo neo dipinto sull'angolo della guancia ed una spruzzatina di lustrini sulla pelle per farla risplendere.
Una discussione a parte meritano i profumi impiegati: non si conosceva ancora il metodo della distillazione, quindi le essenze erano ottenute per spremitura e macerazione, mediante un bagno delle sostanze da cui estrarre l’essenza, in olio di olive verdi o di succo di uva acerba, assieme a coloranti per dare un bell’aspetto agli olii. Alcuni dei profumi erano particolari per i nostri gusti, come il Rhodium, l'essenza derivata dai petali di rosa, l'Illirium e il Susinum ottenuti con varie specie di gigli pompeiani, il Mirtum-laurum dal lauro e dal mirto, il Melinon dalle mele cotogne, lo Iasminum dal gelsomino. Dall'Egitto proveniva il Metopium, tra i cui ingredienti figurava anche il costosissimo "Balsamo di Giudea". Da far notare che le essenze raggiungevano prezzi proibitivi già dal I secolo d.c., quando una libbra di profumo costava anche più di 400 denari. Uno scandaloso spreco, a detta di Plinio, poiché simili ricchezze venivano dissipate "pro fumo", senza alcun effetto se non quello di appagare il piacere altrui, dato che "chi è profumato non si accorge di esserlo".
Ma non si creda che il lavoro delle schiave fosse a questo punto finito. Perché anzi si può dire che qui veniva la parte più complessa, cioè la preparazione della capigliatura della matrona per affrontare il mondo. La cura di questo particolare settore era affidato alle "Ornatrix", costrette a curare con cura maniacale impalcature di riccioli, trecce, nastri e spilloni, sperando di soddisfare a pieno le 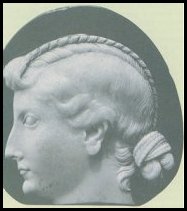 loro padrone, pena le più folli ire delle pretenziose matrone.
loro padrone, pena le più folli ire delle pretenziose matrone. 
 Furono vari i tipi di acconciature che si susseguirono nei secoli: dai capelli semplicemente pettinati all’indietro, stretti sulla nuca o divisi in ciocche gonfie (pettinatura a melone) dell’inizio dell’età imperiale, alle lavoratissime elevazioni coperte di riccioli ottenuti con un ferro rovente, il Calamistrum.
Furono vari i tipi di acconciature che si susseguirono nei secoli: dai capelli semplicemente pettinati all’indietro, stretti sulla nuca o divisi in ciocche gonfie (pettinatura a melone) dell’inizio dell’età imperiale, alle lavoratissime elevazioni coperte di riccioli ottenuti con un ferro rovente, il Calamistrum.
Dal secondo secolo d.C. in poi si aggiungono diademi, nastri, spilloni d’oro ed argento, questi ultimi soprattutto cavi all’interno, a volte contenenti veleno, ed usati anche come difesa ed offesa, ed 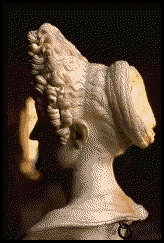 una rete in fili d’oro che serviva a raccogliere i capelli dietro, e che quando mancava poteva essere sostituita con nastri e coccarde.
una rete in fili d’oro che serviva a raccogliere i capelli dietro, e che quando mancava poteva essere sostituita con nastri e coccarde.
Quando erano molto fortunate, le ornatrix disponevano di una padrona calva che quindi ricorreva all’uso di parrucche, sempre elaboratissime, ma che potevano essere preparate con calma e senza una testa sotto che si lamentasse, per la lunghezza del lavoro e per il dolore di qualche manovra. I capelli erano importati dall’India (quando neri) e dal nord Europa (quando biondi).
Si ricorreva anche all’uso di tinture, sia per le parrucche che per le povere teste, utilizzando minerali derivanti dall’antimonio nero, unito a grassi animali, o cenere di assenzio con olio di rosa e infusi di foglie di cipresso intrise nell’aceto per ottenere il nero ed il bruno. Il rosso si otteneva con l’hennè, mentre di origine gallica era la pozione che rendeva bionde le chiome, ricavata da grasso di capra e cenere di faggio. Colori particolari come il turchino o il carota erano appannaggio delle meretrici.
Una nota di colore se la concedevano anche gli uomini, specie il biondo, o addirittura una spruzzata di polvere d’oro, come faceva lo stesso imperatore Commodo.
A questo punto avendo completato la vestizione prima di uscire ci si agghindava con i gioielli, per dare il tocco finale.
Nel periodo repubblicano qualsiasi tipo di lusso era vietato dalla legge, vivendo in una austerità di costumi ed usi, ma nel 193 a.C. le donne si coalizzarono contro questa durezza ottenendo un ammorbidimento degli usi tanto che alla fine Giulio Cesare promulgò una legge che regolava l’uso delle perle.
Gli orefici, che con la fine dell’età repubblicana si moltiplicarono, iniziarono lavorando su disegni greci ed etruschi. Gradualmente questi artigiani perfezionarono la loro arte, importando lavoranti dall’oriente, usando tecniche diverse e materiali importati. Questi si dividevano in Caesellatores, Inauratores, Anularii, Bractearii (questi ultimi battevano foglie di oro sottilissimo tra due strati di cuoio) e Margaritarii ( che si occupavano della lavorazione con le perle). Ed oltre alle perle si introdusse l’uso di rubini, smeraldi, diamanti, topazi, acque marine, pasta di vetro, ambra proveniente dal baltico.
Più erano ricche e potenti le matrone, più i gioielli che portavano dovevano mostrare questa loro importanza. La terza moglie di Caligola, Lollia Paolina, si presentò ad una manifestazione con svariati gioielli che dovevano avere un valore complessivo che si aggirava sui 4.000.000 di sesterzi, come ci racconta Plinio il Vecchio.
I gioielli più usati nel mondo antico erano gli anelli, i bracciali, gli ore cchini, le spille e le collane. Dopo l’introduzione del culto della dea Iside, si usò spesso l’effige del serpente, in bracciali in oro, realizzati con tanto di squame ed occhi in pasta di vetro o pietre preziose, da portare sull’avambraccio o come anelli.
cchini, le spille e le collane. Dopo l’introduzione del culto della dea Iside, si usò spesso l’effige del serpente, in bracciali in oro, realizzati con tanto di squame ed occhi in pasta di vetro o pietre preziose, da portare sull’avambraccio o come anelli.
La collana comunque era il monile più importante, essendo il primo ad essere visto, posto com’è sul petto della matrona. Le maglie potevano essere ad anelli più o meno grandi oppure a matassine di fili intrecciati tra loro, o formate dalla piegatura di nastri d’oro ed argento. Potevano essere corredate da castoni di pietre preziose o monete d’oro, e terminare con un pendente grosso e pesante che dava un senso di equilibrio e stabilità alla composizione. Queste collane potevano raggiungere anche i 40 cm, ed erano sicuramente pesanti.
In una to mba è stata rinvenuta una collana di due metri e mezzo del peso di un chilo usata come cintum, con intrecci particolari attorno al petto, alle ascelle e alla vita. Gli orecchini erano realizzati di qualsiasi tipo e foggia: avevano forma di animale, cuori, anfore, visi, soli, mezze lune, rosette e quanto d’altro. Famosissimi i Crotalia,
mba è stata rinvenuta una collana di due metri e mezzo del peso di un chilo usata come cintum, con intrecci particolari attorno al petto, alle ascelle e alla vita. Gli orecchini erano realizzati di qualsiasi tipo e foggia: avevano forma di animale, cuori, anfore, visi, soli, mezze lune, rosette e quanto d’altro. Famosissimi i Crotalia,  costruiti da più pendenti che terminavano con una perla, chiamati così per il rumore che producevano le perle sbattendo tra di loro con il movimento.
costruiti da più pendenti che terminavano con una perla, chiamati così per il rumore che producevano le perle sbattendo tra di loro con il movimento.
E alla fine si era pronte per uscire, ma non ci si illuda che fosse tutto finito così. Anche perché a questo punto ci si recava alle terme per fare finalmente le abluzioni, quindi il trucco era destinato a rovinarsi. A questo scopo i trucchi erano contenuti in cassette, in modo da seguire la matrona nei suoi spostamenti. Il trucco si faceva alla mattina, si rifaceva dopo le terme e si sfaceva a sera, prima di andare a letto, ma dei metodi usati per togliere quel pesante strato non ci è giunto nulla quindi è probabile che usassero acqua e oli, per ricominciare con le maschere di bellezza.

 a libertà, ma Varo era di un'altra pasta e preferiva agire con spietatezza e ferocia, come aveva già mostrato in Siria, dove, per piegare gli spiriti ribelli aveva fatto crocefiggere 2000 ribelli. Inoltre lui contava sulla vicinanza dei nobili cui aveva promesso cariche di prestigio e ricchezze, e del principe Cherusco, Segeste, padre di Armiliano che per i suoi meriti aveva meritato la cittadinanza romana.
a libertà, ma Varo era di un'altra pasta e preferiva agire con spietatezza e ferocia, come aveva già mostrato in Siria, dove, per piegare gli spiriti ribelli aveva fatto crocefiggere 2000 ribelli. Inoltre lui contava sulla vicinanza dei nobili cui aveva promesso cariche di prestigio e ricchezze, e del principe Cherusco, Segeste, padre di Armiliano che per i suoi meriti aveva meritato la cittadinanza romana. ttembre quando scatta l'imboscata di Arminio e delle popolazioni germaniche, che piombano sui soldati romani da ogni parte, protetti dal folto della foresta.
ttembre quando scatta l'imboscata di Arminio e delle popolazioni germaniche, che piombano sui soldati romani da ogni parte, protetti dal folto della foresta.




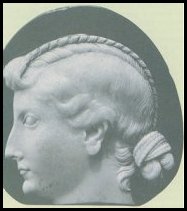

 Furono vari i tipi di acconciature che si susseguirono nei secoli: dai capelli semplicemente pettinati all’indietro, stretti sulla nuca o divisi in ciocche gonfie (pettinatura a melone) dell’inizio dell’età imperiale, alle lavoratissime elevazioni coperte di riccioli ottenuti con un ferro rovente, il Calamistrum.
Furono vari i tipi di acconciature che si susseguirono nei secoli: dai capelli semplicemente pettinati all’indietro, stretti sulla nuca o divisi in ciocche gonfie (pettinatura a melone) dell’inizio dell’età imperiale, alle lavoratissime elevazioni coperte di riccioli ottenuti con un ferro rovente, il Calamistrum.